| |
Anche se è impossibile conoscere con precisione da
quando l'uomo abbia iniziato ad attribuire il nome ai luoghi che lo
circondavano sembra che i primi ad essere stati individuati in modo
diretto siano stati i fiumi e i monti.
Secondo il geografo francese Paul Claval questo è
avvenuto quando le popolazioni, dopo aver occupato in modo stabile i
territori, hanno sentito il bisogno di avere la possibilità di indicare
alcune entità geografiche specifiche.
Lo studio linguistico storico pone l'attenzione sui
toponimi perché le radici di questi mantengono informazioni anche
attraverso il passaggio dalla lingua che viene abbandonata a quella che
ne prende il posto e in assenza di altri dati il nome può essere dunque
la testimonianza di lingue e di civiltà completamente estinte.
Ciò che ha cessato di esistere ha lasciato cioè
tracce nei nomi locali legati ai luoghi abitati (paesi, contrade, vie e
attività economiche), alle entità geografiche (vallate, monti,
insenature, isole, laghi e mari) ed ai diversi corsi d'acqua (sorgenti,
torrenti e fiumi)
Nella cultura anglosassone possono rientrare in tale
definizione anche particolari zone naturalistiche come prati, radure e
boschi.
Per alcuni autori è possibile allargare il campo di
interesse della toponomastica anche a monasteri, chiese, altri edifici
religiosi e comprendendo tra questi anche i siti di sepoltura.
La toponomastica permette di conservare la cultura
locale e richiede il mantenimento di banche dati specifiche.
Dati cartografici e toponomastici possono essere
diffusi in vari formati compresi mappe topografiche cartacee e digitali.
La toponomastica italiana dalla sua nascita, fine XIX
secolo, ha sempre tenuto presente l’interesse per lo studio storico del
territorio, come dimostrano numerose pubblicazioni di linguisti e
geografi. Odiernamente lo studio dei microtoponimi e dei termini
geografici, serve per illustrare l’evoluzione di un territorio storico
nella sua completezza.
Nell’ambito della disciplina geografica e
particolarmente di quella geostorica, la ricostruzione di un paesaggio
antico, sia questo preistorico, medievale, moderno, ma ormai anche
“quasi” contemporaneo, non può assolutamente prescindere dall’apporto
della toponomastica, in quanto come affermato da Giovan Battista
Pellegrini,: «il compito istituzionale della toponomastica è
soprattutto di studiare i nomi locali nelle loro origini e nella loro
storia e di indagare sulla nomenclatura degli oggetti geografici. Lo
studioso che si occupa di questo ramo delle esplorazioni
linguistico-etimologiche ha come compito fondamentale di ridare al nome
di luogo, divenuto per lo più opaco nel corso dei secoli o dei millenni,
una trasparenza, un significato o di formulare delle ipotesi che siano
per lo meno verosimili per l’aspetto storico-geografico e soprattutto
per l’interpretazione linguistica fondata sul metodo storicocomparativo
(sviluppatosi scientificamente solo a partire dai primi anni del secolo
passato)»
|
Elenco di alcuni nomi in Valdichiana e cenni
storici |
|
AIA (Rigomagno) Il
toponimo, piuttosto frequente, nelle sue varie forme e
grafie, deriva dal latino aream, ‘uno spazio largo e
aperto’; alcuni lo connettono al greco aloa, aloe, ‘aia’,
congiunto ad aloào, ‘trebbiare’, ‘battere il grano’; altri
preferiscono orientarsi sul significato di ‘superficie piana
e libera’. Si tratta comunque di uno spazio aperto di
terreno, spianato e accomodato per battere il grano.
Incontriamo Poggio all’Aia a Siena, L’Aia a Radda (SI), e
ancora Aiaccia a Piancastagnaio (SI), e a Gaiole (SI),
ancora Aia-nuova, Aiale, Aialino, Aiola, ecc. Nel toponimo
sinalunghese si tratta di una località con una bella villa
posta su un’altura su cui si adagia un luogo pianeggiante.
|

Nell'aia - 1954 |
AIA DELLE COSTE (Bettolle) Un’aia, cioè un’area, uno
spazio vasto e aperto, delimitato da coste, cioè i fianchi
di un poggio.
Costa
deriva dal latino costam, “fianco del poggio o del
monte”. Incontriamo Coste (-alte, -basse) a
Siena, Costaglie a Radicòndoli (SI), Costaglia
a Chiusdino (SI), Costalpino.
|

Bettolle, Aia delle Coste bassa |
AIOLÀ - (e Aiolà I, II,
III) Vi sono 5 Aiolà in provincia di Siena, il
toponimo quindi è abbastanza raro. Occorre aggiungere 4
Aiole (nella forma plurale) e un diminutivo Aiolina
(a Castelnuovo). Un po' più diffuso è Aia, articolata
a sua volta in Aia, Aiaccia, Alale, Aiamonti,
Aiavecchia, ecc. Il termine "Aiolà", attestato già nel
sec. XIII, deriva dal latino areola, diminutivo di
aream, 'uno spazio largo e aperto'; alcuni lo connettono
al greco aloa, aloe, 'aia', congiunto ad aloào,
'trebbiare', 'battere il grano'; altri preferiscono
orientarsi sul significato di 'superficie piana e libera'.
Si tratta comunque di uno spazio aperto di terreno, spianato
e accomodato per battere il grano. Da questa funzione
specifica e dalle caratteristiche anche estetiche e
funzionali del luogo, del terreno, prese il nome,
verosimilmente, il podere.
|

Podere dell'Aiola II, dei tre. |
AMOROSA
Splendida, antichissima
fattoria, un gioiello del territorio sinalunghese. Le sue
dolci colline erano già abitate in epoca etrusca e
continuarono ad esserlo in quella romana. “Citazioni
relative a l’Amorosa si hanno a partire dal XII secolo, per
lo più in documenti notarili, mentre la prima notizia
importante (…) ci viene da un fatto d’arme che si sviluppò
nel nostro territorio nell’ottobre 1363”.
Nel
medioevo fu un castello della campagna senese, e seguì le
vicissitudini di quello di Sinalunga. Successivamente fu
centro di una vasta tenuta, con tutte le strutture agricole
del caso: cantina, granaio, stalla, ecc. Ma disponeva anche
di un’osteria, di una scuola e di una chiesa (intitolata a
Santa Maria Assunta) per tutta la comunità rurale. È stata
per lungo tempo una grande tenuta di cui facevano parte
numerosi poderi.
È
suddivisa tradizionalmente in un Borgo centrale e in vari
poderi circostanti.
Alcune ipotesi etimologiche su Amorosa:.
1) Si suppone che il
nome derivi dal torrente Amorosa “che ne percorre il suolo
dal lato di levante”.
2) “Il
toponimo “Amorosa”, simile alla Gamurisa del Chianti (cfr.
S. Pieri, Toponomastica della Toscana meridionale), deve il
suo nome al locale tempio della dea Carmenta, detta Carmilla
e Cameria Melite, nel Geronimiano.
A Chiusi esistevano nel
periodo etrusco una famiglia che riporta il nome del dio Velthina ed un’altra che ha il nome della dea
Camurisa". Da
quanto sopra, si potrebbe dedurre che Amorosa è una
‘corruzione’ del nome originario; oppure si potrebbe
parlare, in un certo senso, di una etimologia edificante o
di una paretimologia.
3)
Se, invece, assumiamo il termine Amorosa come
originario, potremmo dire che, comunque, la denominazione
esprime anche la bellezza e la meraviglia del luogo, e
questo, forse, potrebbe essere entrato come elemento di
formazione del toponimo.
Il
termine amoroso/a in italiano ha varie accezioni,
quella che ci sembra più attinente al nostro toponimo è
un’accezione non comune, ma sicuramente la più indicata:
“che suscita amore” (come il filtro amoroso…), o quella
poetica: “piacevole, amabile”, come nel dantesco
l’amorosa leggiadria (Vita Nuova). La parola è citata
anche nel Vocabolario della Crusca, con analoghi significati
e con una preziosa citazione tratta dal sonetto 91 del
Petrarca: “Tosto che giunto all’amorosa reggia...”.
|

Interno Fattoria dell'Amorosa |
|
|
BANDITA (e Bandita II - Bandita terza - Bandita ultima -
Eremo della bandita) (Bettolle - Farnetella - Scrofiano)
Bandita deriva dalla parola di origine gotica bandvjan. Il
verbo bandire va inteso nel senso di ordinare, interdire
(confronta il termine bando).
Si
tratta di un concetto strettamente legato al feudalesimo:
designa le proprietà destinate all’utilizzo esclusivo del
signore locale, sulle quali era tassativamente vietato il
taglio e la raccolta della legna, la caccia e talvolta anche
il passaggio.
In un
senso più vicino alla comprensione del nostro toponimo la
bandita è “un luogo nel quale è proibito il cacciare, il
pescare, l’uccellare per pubblico bando”.
Con
significato leggermente diverso, per bandite, si intendevano
“territori comunali dove erano esercitati alcuni diritti
esclusivi, ad esempio il legnatico (uso civico consistente
nel diritto di far legna in un bosco di proprietà
comunale)”. Si disse in passato “Tener corte bandita” il
banchetto cui il signore del luogo invitava per pubblico
bando.
Il
toponimo Bandita si ritrova in vari comuni, a Torrita (un
podere), un diminutivo, Banditello a Rapolano, come
collettivo, Bandite a Cortona, Castiglion Fiorentino.
I
nomi di luogo con un medesimo tema, che si ripetono, in
un’area vicina, confermano l’intuizione e la necessità
suggerita da alcuni studiosi:
“È
progressivamente operante anche una forte propensione a
vedere il toponimo inserito in un «reticolo»”.
“In
un poggio presso Farnetella (l’Eremo della Bandita, chiamato
da tutti il Romitorio) viveva un misterioso abitatore. Il
poggio anticamente apparteneva al Comune di Farnetella e
successivamente di proprietà degli antichi signori del
castello”.
|

Podere della Bandita |
BAREGNO (fosso) Corso d’acqua lungo circa 4 chilometri,
2 da Sinalunga e gli altri tra Cortona e Foiano.
Viene
registrato sia il torrente Baregno sia il fosso Baregno.
Sappiamo che nella toponomastica toscana il fosso è da
intendersi anche come corso d’acqua. Riguardo all’etimologia
del toponimo: non è semplice, spesso i corsi d’acqua hanno
nomi molto antichi, talora preromani.
Inoltre il nome non di rado subisce una evoluzione fonetica
che rende difficile risalire alle origini.
Nel
libro di Pieri sulla toponomastica toscana meridionale si
cita Baregno e Berigno (l’autore afferma essere tipici
dell’aretino) e i simili Berignone e Bergnona, proponendo
due ipotesi etimologiche:
1)
Dal latino balneum - balineum, ‘bagno’.
2)
Forse hanno una connessione anche con una base Verinio, dal
nome Verinius. Potrebbe esserci anche una relazione con una
voce dialettale umbra, bregno, ‘greppo’, ‘piega,
piegatura’; bregno pare sia una continuazione del latino
balineum, ‘bagno’, attraverso forme intermedie del tipo
baregno, barigno.
|

Fosso Baregno, in piena, con
la chiavica che passa sotto al Torrente Foenna
nella zona di Rotone |
BERTESCA (Guazzino)
Dal latino medievale brittisca (m), probabilmente
derivato da brittus, “bretone”, propriamente
“fortificazione di tipo bretone”.
1) Opera difensiva in
muratura o in legno costruita fra i merli delle antiche
fortificazioni o posta in aggetto alle mura.
2) Nel linguaggio dei
cacciatori, è il piccolo osservatorio con feritoia,
posto in cima al capanno, per osservare il volo degli
uccelli.
Anche il vocabolario della
Crusca del 1612 cita questo termine: “Spezie di riparo
di guerra, che si fa in su le torri, mettendo tra l’un
merlo, e l’altro una cateratta, adattata in su due perni
in maniera, che si possa alzare, e abbassare, secondo il
bisogno de’ combattenti”. Il toponimo sinalunghese forse
trova la sua spiegazione in uno di questi campi
semantici.
|

Bettolle dalla località Bertesca - 2007 |
BETTOLLE
Frazione di Sinalunga, un tempo fu comune autonomo;
venne definitivamente e ufficialmente aggregato al
comune di Sinalunga nel 1778. È a 308 metri slm.
Alcune ipotesi etimologiche sul nome:
1)
“L’origine del nome è incerta, riconducibile,
secondo alcuni, alla presenza di un bosco di Betulle
(Betula), secondo altri dal nome etrusco di persona Petui (trasformato poi in Bettonula, poi Bettona ed
infine Bettola)”. “La f ioritura di questo abitato
etrusco è da ricollegare alla posizione strategica
della collina (m. 308 slm.) di Bettolle rispetto al
Clanis; inoltre lo stretto rapporto dell’abitato
antico con il fiume, già evidente per la posizione
su un promontorio isolato, ben difendibile e
leggermente arretrato rispetto alla foce del Foenna
nel Clanis, si dimostra con migliori argomentazioni
considerando l’ubicazione delle necropoli scavate
nel secolo scorso”.
“Questo bel villaggio,
a cui probabilmente diedero nome le betulae
(ontani)”.
La betulla è un albero
dai rami sottili, talvolta penduli, con foglie a
forma di rombo che hanno proprietà depurative, legno
flessibile e corteccia biancastra, da cui si ricava
un olio balsamico, resine e il tannino. Dal latino
betulla(m), di origine celtica.
2) Forse
da bettola, osteria di infimo ordine; taverna. Etimo
incerto, forse connesso con baita. La baita è una
piccola costruzione di sassi o di legno, usata come
ricovero in alta montagna; forse deriva dall’antico
alto tedesco Wahta, guardia. Come nel toponimo
Bettola.
3)
Probabilmente connessa col termine bastia,
fortificazione, dall’antico francese bastie, a sua
volta dal germanico bastjan, ‘costruire’.
4)
Potrebbe avere relazione con la voce Battù, Battud,
via de Batudo, con riferimento ad un “terreno
battuto”, “terra battuta” o anche “via battuta.
5)
“Bettolle, toponimo derivante come Beltona- Bettona,
nella forma Beltonule-Bettolle, dal nome del dio Beltone-Veltune?
Il moderno complesso
urbano di Bettolle si è sviluppato intorno al
piccolo centro medievale, del quale restano
pochissime tracce, e alla “Reale Fattoria”
appartenuta per lungo tempo ai Cavalieri di Santo
Stefano e poi ai Granduchi di Toscana.
La Fattoria di
Bettolle era una delle più importanti del
Granducato. Oggi restano: la splendida villa, ancora
intatta e moltissimi fabbricati rurali, conosciuti
come “Poderi Leopoldini” perché costruiti su volere
e con le indicazioni del Granduca Pietro Leopoldo di
Lorena.
Sul territorio
immediatamente a valle di Bettolle scorre il Canale
Maestro della Chiana, sui cui argini si possono fare
delle passeggiate rilassanti, lontano dai rumori
della vicinissima autostrada A1 e degli svincoli
della superstrada Siena-Perugia.
Dopo la “guerra di
Siena” (metà del XVI sec.) il territorio di
Bettolle, immerso nelle paludi, fu sottoposto ad un
imponente lavoro di bonifica. Questa opera complessa
avvenne col sistema delle “colmate” largamente usate
in altre zone della Valdichiana soprattutto nel
XVIII sec. Bettolle è suddivisa in cinque contrade:
Il Casato, Le Caselle, Montemaggiore, La Ceppa e Il
Poggio.
|

Bettolle |
BISCIANO
(Bettolle) Probabilmente il toponimo ha una
formazione prediale, cioè relativa ad un podere.
Fa riferimento ad un nome personale antico,
Bessianu, Bessius più il suffisso aggettivale
latino, segno di possesso, -anus, che risulta
-ano in italiano. Incontriamo il toponimo anche
a Foiano della Chiana. Altra ipotesi: esiste una
località pistoiese, El campo del Biscedo, in cui
la voce biscia è considerata di origine
germanica dallo storico Muratori; forse tra Bisciano e
Biscedo potrebbe esserci qualche
analogia e comune origine.
|

Bettolle, Bisciano |
BUCA DEL SERPE
(Rigaiolo) Il Pieri cita questo toponimo
sinalunghese in un suo libro nel capitolo di nomi
locali derivati da nomi di animali.
Il toponimo potrebbe
fare riferimento ad una realtà effettiva, la
presenza in una certa zona di serpenti, notata e
registrata, anticamente, dalla popolazione.
In passato nacque e si
consolidò una “toponomastica spontanea, popolare”.
“Per la maggior parte delle città italiane, non si
può parlare di una vera e propria toponomastica
ufficiale, cioè imposta e regolamentata da una
autorità, prima del secolo XIX.
Fino a quell’epoca la
grande maggioranza dei nomi delle strade era il
prodotto di particolari condizioni locali della più
varia natura: caratteristiche fisiche dell’ambiente,
trasposizioni di nomi o soprannomi di persone,
ricordi di fatti e fatterelli di storia o più spesso
di modesta cronaca quotidiana, sopravvivenze di nomi
locali antichissimi. (…)
Si trattava quindi di
una toponomastica che, per contrasto con quella
ufficiale, si potrebbe chiamare «spontanea», cioè un
prodotto del sentire e del parlare del popolo,
mantenuta in forza di un uso quotidiano che non
subiva interferenze di alcuna autorità e soggetta a
variare solo per il mutare delle ragioni e delle
condizioni che l’avevano originata”. “Al di là
della fiumara, sul costone dove cominciava il fondo
chiamato Chinigò, il terreno nudo brulicava di
serpenti: erano decine, serpenti di ogni tipo e
grandezza, che uscivano dal nulla e si allacciavano
sugli altri fino a formare un cerchio, una ruota, un
mucchio informe e mobile, poi sgusciavano fuori a
casaccio e strisciavano su e giù, instancabili,
velocissimi, vibrando come sciabole le loro lingue
biforcute, lanciando in coro un sibilo continuo.
Pareva che in quel luogo si fossero dati
appuntamento tutti i serpenti delle colline
circostanti”. Tornando al toponimo sinalunghese,
l’allusione quindi poteva essere ad una situazione
reale, concreta, osservata dalla gente. Oppure
l’origine potrebbe essere in un soprannome. O
derivare da una leggenda. Da un antico racconto
popolare. Da qualche diceria o credenza
tradizionale.
|

Rigaiolo, zona Buca
del Serpe |
BURRAIA
(Bettolle) (un fabbricato annesso alla Villa Passerini,
conosciuto come “La Burraia”). Termine antiquato italiano:
nelle abitazioni rustiche, locale in cui veniva preparato il
burro e più in generale adibito alla lavorazione del latte.
Il toponimo ricorre spesso
in Toscana: erano costruzioni rurali edificate nelle
zone di pascolo, lontane dai paesi o dalle abitazioni
dei pastori, quando non era possibile trasportare il
latte per la lavorazione. Ma è raro in provincia di
Siena, dove lo incontriamo solo a Sinalunga e, nella
forma Burraio a Montepulciano.
Le burraie venivano
costruite nelle zone di alpeggio (pascolo estivo in alta
montagna, parola derivata da alpe) in prossimità
di sorgenti o corsi d’acqua e la costruzione garantiva
una bassa temperatura interna. Come burraie a volte
venivano utilizzate le grotte.
Talvolta una burraia era
condivisa tra più pastori che si organizzavano in turni
per l’utilizzo e la manutenzione della burraia stessa.
In Toscana è stato
organizzato un Parco che promuove escursioni e
riscoperte naturalistiche, che prevede anche il percorso
del “Sentiero delle Burraie”, talora ancora presenti sul
territorio, seppure spesso diroccate. Sempre in Toscana
esiste un agriturismo chiamato La Casina della
Burraia, un antico casale con annessa la vecchia
costruzione della burraia, ancora oggi funzionante.
|

Bettolle, zona della
Burraia |
BUTARONE, Anche
questo loponimo è un Hapax, cioè unico, almeno nel
contesto della provincia di Siena. Lo incontriamo (ma
leggermente diverso) nella località Vocabolo Butarone,
a Città della Pieve (PG), e all'inizio della Chiana
Romana come torre fortificata costruita riadattando un
antico molino.
E' alquanto misterioso per
formazione e significato. Forse l'esito di una
"corruzione" linguistica avvenuta nel corso del tempo e
legata alla parlata popolare. Si può azzardare
un'ipotesi con l'ausilio di Silvio Pieri, il maggiore
esperto di toponomastica della Toscana, che in
Toponomastica della Valle dell'Arno cita Buta,
Butia, Bufi, Butale, collocandoli nel capitolo dei
nomi locali spettanti alle condizioni del suolo, vedendo
in quella radice buta, la parola latina bucita/bucetum,
"pascolo", luogo dove pascolano i bovini. Potrebbe
butarone essere un accrescitivo di buta/bucitaì?
Ricordando che nel Senese vi sono 9 toponimi
Mandria/Mandrie, probabilmente con un significato
analogo.
|

Leopoldina del Podere
Butarone nella zona di Rotone |
|
|
CALCIONE (Rigomagno)
Era parte di un possedimento dei Marchesi della Stufa
(anticamente venivano citati anche come Marchesi delli
Stufi). Questi nobili erano chiamati anche Marchesi del
Calcione. Il loro titolo era denominato anche Marchesato del
Calcione.
La famiglia Lotteringhi faceva
parte dell’antica aristocrazia fiorentina, forse di origine
germanica. Già alla fine del XIII secolo la loro ricchezza
era in parte procurata dal possesso della Stufa (bagni
pubblici) e che alla lunga li avrebbe portati a modificare
il cognome in Lotteringhi della Stufa.
Il Repetti alla voce Badia
di Capolona nel Val d’Arno aretino del suo Dizionario
Geografico-Fisico-Storico della Toscana accennava che
nei secoli moderni questa badia “l’ebbero in commenda molti
individui della famiglia fiorentina Lotteringhi della Stufa,
per diritti probabilmente portati in questa casa da una
erede dei conti Montedoglio.
La famiglia era iscritta nel
Libro d’Oro della nobiltà di Firenze, e poggiava il titolo
marchionale su Calcione, una loro proprietà nei pressi di
Siena”.
Questa famiglia fu
proprietaria anche del Castello di Gargonza (oggi nel
territorio del comune di Monte San Savino) dal 1546 sino
alla fine del ’600.
Riguardo al nome Calcione,
probabilmente precedente, come formazione, alla famiglia
nobile che lo possedette, è verosimile che abbia origine da
un antico nome personale calli; campiello è una voce veneta
che deriva dal latino etrusco: Calcena, latino Calcinius.
Ad es. Calcéno, podere in poggio, a Castelnuovo
Berardenga (SI).
Calcino (Pieve di
Pacina). Calcena-o, ad Asciano (SI)79. Nel comune di
Gaiole in Chianti (SI) esiste il toponimo Montecalcini,
che viene fatto derivare dall’etrusco Calcena.
“La Corte di questa Terra
confina con quella di Lucignano, col Marchesato di Calcione
degli Stufi, colle Corti delle Serre, e Farnetella, e co’
Comunelli di Modanella, e di S. Gimignanello. Passano per
questa Corte i Fiumi della Foenna, e delle Vertighe”.
L’idea che il nome Calcione
potrebbe essere in relazione con una particolare
costituzione del terreno, ricca di calcio, è forse un caso
di etimologia popolare o di paretimologia. Infatti, fino a
qualche decennio fa, qui vi era una gora con una
cava, in cui si ricavava calce.
Del resto vi sono in Toscana
toponimi simili che si ritiene derivino dal tema calce, dal
latino calcem, come ad es. Calcaia a
Castelnuovo Berardenga e ad Asciano; Calcinaia a
Buonconvento e ancora: Calcinaio a Radicofani (SI).
“Gli altri monti hanno una
composizione quasi simile, ed in fatti i minerali sono i
medesimi che ho notato trovarsi nel poggio d’Asinalunga,
vale a dire alla base dei monti la calce carbonata, in
seguito il grigiovachio, ed in fine il tufo marino.
I minerali sono i seguenti:
Galce carbonata compatta, o alberese; si trova alle Poje.
Grigiovachio celeste; ve ne sono di grandi altezze da farne
colonne ed altri lavori di architettura; si trova nel podere
Ceppi, ed all’altro di Niccoluccio. Arena silicea, che può
essere utilmente impiegata per la fabbricazione del vetro:
a’ poggi Screzzi. Legno impietrito: a Costarlaja; legnite
terrosa al Castalletto. Agate e diaspri, nelle cave di
ghiaja di Niccoluccio, ed alla Madonna di Gallo”.
|

Castello del Calcione |
CALLONE Accrescitivo di
calla, nelle opere di presa di un corso d'acqua costituite
da uno sbarramento con luci laterali, apertura chiudibile
con una paratoia. Per estensione la paratoia stessa.
L'etimologia di callalcallone è dal latino tardo
càlla(m), per il classico càlle(m), "calle, via
stretta".
Callone di Valiano: la
costruzione del callone fu decisa nell'incontro
avvenuto nel 1718 a Città della Pieve fra i plenipotenziari
del Pontefice Clemente XI e di Cosimo III, granduca di
Toscana, per la stipula di una Concordia.
In quella sede il senatore
Giuseppe Ginori, per conto del granducato, ordinò la
costruzione dell'opera realizzata dall'ing. Giovanni Franchi
che fu ultimata nel 1723. Fu realizzata per regolare sia il
livello delle acque dei laghi di Montepulciano e di Chiusi,
sia lo scarico delle medesime nel Canale Maestro anche ai
fini di assicurarne la navigabilità. Questo rappresentò a
lungo la principale via di trasporto dei prodotti agricoli
verso i mercati di Arezzo e soprattutto di Firenze.
L'opera era composta dal manufatto di regolazione e da due
argini laterali che si attestavano rispettivamente
all'argine del Salarco e alle vicine colline, ricadenti
nello Stato Pontificio. Il manufatto di regolazione era
composto da due fabbricati, uno di modeste dimensioni
articolato su un livelllo l'altro articolato su tre piani.
Nel piano terra furono realizzate tre aperture: il Callone,
la Caletta di Mezzo e la Caletta Esterna, provviste di
paratoie per il transito delle barche. Il Callone cessò la
funzione di regolatore nel 1944 quando fu distrutto a causa
della guerra.
I resti sono stati
recentemente restaurati.
Il Callone Pontificio del
Campo alla Volta
Il regolatore, progettato da Egidio Maria Bordoni con la
collaborazione di Antonio Felice Facci, fu la prima opera
seguita in amministrazione diretta dallo Stato Pontificio
nelle Chiane.
Il fabbricato, a due luci con
quattro cataratte, funzionò dal 1727 fino al 1786, quando fu
abbassata la platea e furono tolte le paratoie.
Nel 1786, fu arricchito con
una iscrizione commemorativa e, nel 1795, con una lapide
celebrante la vittoria dell’uomo sulla palude che fu firmata
da Andrea Vici, Architetto della Sacra Congregazione delle
Acque.
|

Callone di Valiano sul Canale
Maestro della Chiana |
|

Callone Pontificio del Campo
alla Volta, regolatore delle acque della
Chianetta |
CASALBOSCO (Guazzino)
Il significato del toponimo è palese: un casale
immerso nel bosco che, un tempo, all’epoca della formazione
del toponimo, era un elemento di novità da registrare.
Il termine casale
concorre alla formazione di numerosi toponimi. È il latino
casalis, propriamente ‘della proprietà’; il termine
può avere il significato generico di ‘caseggiato’, e ‘casa
isolata rurale con i terreni annessi’, ma forse la maggior
parte dei toponimi rifletterà casalis (sottinteso
fundus), nel senso di ‘case abitate da servi o coloni’,
o ‘gruppo di case coloniche’, ‘aggregato di case rurali’.
Quest’ultimo caso corrisponde
al valore di casale nel Medioevo, quando è un
‘insieme di fabbricati contigui difesi generalmente da
mura’.
|

Casalbosco - casale immerso
nel bosco |
CASATO (Bettolle)
La parola casato anche in italiano ha due
accezioni:
1) stirpe, famiglia,
lignaggio.
2) (antiquato): nome di
famiglia, cognome. Deriva da casa.
Il toponimo sinalunghese
si riferisce ad una residenza storica del 1600, che fu
già proprietà dei Piccolomini.
Casato è anche uno dei
rioni storici di Bettolle.
E. Repetti, Dizionario
geografico fisico storico della Toscana, sei volumi,
Firenze 1833, Vol. 1°: “Non molto discosto da
Bettolle, al luogo detto il Casato, è stato eretto
modernamente un ameno casino dal cav.
Bandini-Piccolomini di Siena”.
|

Bettolle - villa del Casato |
CASELLE (Bettolle e
anche a Farnetella) In toponomastica è più frequente
incontrare il plurale di Casella. (casella sta
per casupola, capanna, piccola costruzione per pastori,
ecc.). Da confrontare anche col latino Casellis,
‘aggregato di casupole pastorali’.
Nella provincia di Siena c’è
in molti comuni, con le varianti Casellette a S.
Quirico, Caselli a Siena, Castellina, Montalcino e
Murlo.
Frequente anche in altri
contesti geografici, ad es. Caselette (TO), Caselle in
Pittari (SA), Caselle Landi (LO) Caselle Lurani (LO),
Caselle Torinese (TO), e ancora Via Caselle (BO), ecc.
E. Repetti, Dizionario
geografico fisico storico della Toscana, Vol. 1° :“Caselle
di Bettolle in Val di Chiana: Villa fra il torrente Foenna e
il Canale maestro della Chiana nel popolo di S. Cristofano a
Bettolle”.
CASELLE ALTE (Bettolle)
Forse, in origine, casupole erette su un poggio, un’altura,
così definite per distinguerle da altre, costruite, abitate,
in una zona pianeggiante o scoscesa.
|

Bettolle, Caselle Alte |
CASTELLINA (a Guazzino
e vicolo Castellina a Scrofiano) Diminutivo di
castello.
Identico toponimo lo
incontriamo a Montalcino, Monteroni, Montepulciano, Gaiole e
un podere con tale nome a Sovicille.
Altri diminutivi del tema
castello che si incontrano in toponomastica: Castelletto,
Castelluccio, Castiglioncello, Castiglionchio, Castellonchio,
ecc.
E. Repetti, Dizionario
geografico fisico storico della Toscana, Vol. 1°:
“Castellina di Asinalunga in Val di Chiana: Villa nel popolo
di S. Maria delle Grazie al Guazzino, nel piv. Com. Giur. e
2 migl. a grec. di Asinalunga, Dioc. di Pienza, già di
Arezzo, al cui Comp. appartiene. Trovasi sulla strada che
porta da Asinalunga a Fojano, tra la Foenna e l’Esse,
|

Guazzino (Repetti -
già
Santa Maria delle Grazie alla Castellina) |
CEPPA (Bettolle) Dal
latino cippus, italiano ‘ceppo’. Incontriamo toponimi
come Ceppaia, in diverse zone, Cepparello a Barberino
d’Elsa, Borro dei Cepparelli a Montereggi, e
ancora Ceppato, Ceppeto, Ceppeta.
Per l’etimologia voce analoga
Ceppi. céppa s. f. [da ceppo].
1) Parte dell’albero che sta
sotto terra e in parte a fior di terra, e da cui si
dipartono le radici: certi funghi che produce la c. del
faggio (Giusti).
2) Ceppo cavo del castagno o
d’altro albero: era corso a rifugiarsi nel cavo d’una c. di
castagno (Fucini).
|

Bettolle, località La Ceppa |
CHIANA (Fiume / Val di)
Il nome deriva da quello del fiume Chiani,
anticamente Clanis, “il corso d’acqua fangoso”, da un
tema preromano Cla- / Glan-.
Come spesso accade, il nome
del fiume denomina poi il territorio intorno; in questo caso
si tratta dell’ampia vallata pianeggiante che si estende, a
sud-ovest, tra le province di Siena e Arezzo.
Il fiume, conosciuto oggi come
Chiana, un tempo era affluente del Tevere,
successivamente fu deviato dai Romani per immetterne le
acque in Arno.
Compresa tra l’Antiappennino
toscano a ovest e il subappennino umbro a est, l’area si
ricollega a nord con la conca di Arezzo e a sud con la valle
del fiume Paglia tributario del Tevere.
Un tempo tristemente famosa,
oggi la Valdichiana unisce il fascino antico, con alcuni
ricordi della palude e del duro lavoro fatto per la
bonifica, con quelli moderni della produzione agricola.
Giuseppe Giuli, Statistica
agraria della Val di Chiana, Tomo primo, Libro secondo,
Pisa 1828: “La Chiana è il principale fiume che esista
nella Comunità, quantunque serva di separazione tra essa e
l’altra di Cortona. La Foenna scorre per varie miglia nel
suo territorio. Il Galegno nasce e termina il suo corso
nella Comunità, tributando le sue acque alla Foenna. I
compilatori francesi del Dizionario d’agricoltura, che è
stato poi tradotto e pubblicato a Padova, parlando di
colmate, sembra che per il nome di Foenna essi intendano un
torrente qualunque, con il quale si può fare questi lavori,
mentre è proprio del divisato torrente. Anche nella Comunità
d’Asinalunga vi sono dei canali, che passano sotto l’alveo
d’alcuni torrenti, e tali sono il canale delle Prata che
passa sotto la Foenna, e l’altro dell’Amorosa che passa
sotto il Galegno. Vi sono altri torrentelli, di cui non farò
parola”.
“Di queste terre venivano, nei
rapporti ufficiali, valutati essenzialmente gli aspetti
negativi dell’insalubrità dell’aria e la conseguente
necessità del risanamento e recupero delle aree paludose a
fini produttivi. Anche alcune testimonianze letterarie
classiche fanno riferimento alla loro malsanità. Dante, nel
XIII canto del Paradiso (21-24) fa riferimento al Chiana
come un fiume paludoso (…).
Tanto vera e generale
addivenne la notizia della condizione miserevole della
nostra Valle in quel tempo che la parola Chiana infine si
usò quale sinonimo di luogo paludoso e infetto (…).
E gli stessi Accademici della
Crusca arrivarono a fare del nome proprio Chiana un
nome comune che significasse palude o acqua morta”.
“La prima menzione veramente
esplicita e sicura del fiume Chiana (Clanis) e della
sua Valle ci è data da Appiano Alessandrino celebre storico
delle guerre civili che travagliarono Roma nel primo secolo
av. l’E. V.
Egli narra il fatto d’arme che
nell’anno 82 av. C. avvenne fra L. Cornelio Cinna ed il
fiero campione di parte Mariana Papiro Carbone (…) e
questo fatto d’arme memorando si svolse interamente sul
fiume Chiana”.
“Chiana e chiane, con la
minuscola: i termini vengono usati per indicare “palude,
luogo paludoso”, per similitudine con il lento corso del
fiume Chiana; nel Dizionario della lingua italiana di
N. Tommaseo-B. Bellini del 18611879”155.
|

Canale Maetro della Chiana |
|

Canale Maestro della Chiana
nei pressi del ponte della SP 28 di Via di
Cortona |
|

Canale Maestro della Chiana -
Botte allo Strozzo |
COLLALTO (Farnetella)
Il colle che rappresenta il punto più alto del paese, da qui
il nome. Il colle, dal latino colle (m) è un rilievo
d’altezza intermedia tra l’altura e la collina.
Vi è anche una seconda
accezione: passo o valico montano, ed entra come componente
in molti nomi di luogo, anche nella forma tronca col;
esempi: Colle di Val d’Elsa, Col di Lana, ecc.
Colle Val d’Elsa è suddivisa
in Colle Alto e Colle Basso.
In un territorio di colline,
colli, poggi, alture, ecc., un colle più alto degli altri,
ben visibile, luogo di protezione e ricco di fascino, era
motivo di distinzione che si traduceva nella creazione di un
toponimo.
La zona di Collalto, ad
ovest del capoluogo, è la più elevata di tutto il Comune di
Sinalunga, è ricca di boschi, vigne ed oliveti, offre un
panorama a tutto tondo: da nord a ovest le colline del
Chianti, la città di Siena e il monte Amiata; da est a sud i
sobborghi di Arezzo, tutta la Valdichiana e il monte Cetona.
In lontananza, verso sud-est, il lago Trasimeno e la catena
degli Appennini fino ai monti Sibillini.
E. Repetti, Dizionario
geografico fisico storico della Toscana, Sei volumi, Firenze
1833, Vol. 1°: “Il territorio di Asinalunga tocca per
breve tratto quello di Asciano, il quale contatto segue sul
vertice del poggio denominato Collalto alla pietra de’ 4
termini fra Casabianca e lo sbocco della via comunicativa di
Scrofiano”.
Luigi Agnolucci, Raccolta di
notizie storiche in ordine cronologico del comune di
Sinalunga (fino al 1558): “Colline di Collealto, che
separano la valle dell’Ombrone da quella della Chiana. Su
queste colline sorgono i castelli di Scrofiano, Farnetella e
Rigomagno”.
Pro-Loco Sinalunga, Sinalunga
1999, frammenti di tradizione e vita quotidiana:“Durante
il Pliocene (1-5 milioni di anni fa) l’odierna Val di Chiana
era completamente sommersa dal mare; in sostanza, la nostra
era una zona costiera, con tanto di scogliere e spiagge, le
cui tracce si possono tuttora osservare nei dintorni di
Collalto (dove sono presenti ciottoli di spiaggia, sabbie
litorali e abbondanti fossili marini)”.
|

Collalto |
COLMATONE Unico
in tutta la provincia. C'è Colmata (6 volte) e a
Torrita anche Colmatino (un podere).
Il termine è un vero e proprio
"fossile linguistico" in quanto testimonia un fenomeno
storico, quello della bonifica della Valdichiana.
Colmata, da colmare, è il riempimento di una depressione o
di una zona di terreno a bassa quota, ottenuto convogliando
per mezzo di canali, detti colmatori, sul terreno da
bonificare, acque torbide che lasciano sedimentare i
materiali solidi contenuti in sospensione.
Bonifica per colmata: bonifica
eseguita con tale sistema. Colmata viene detto anche il
terreno stesso che viene in tal modo rialzato.
|

Colmatone, zona Valiano |
CORRIDORE (Guazzino) Toponimo
di significato piuttosto oscuro.
Forse da avvicinare a
corsoio, probabilmente da intendere per corridoio;
c’è Il Corsoio, podere a Sassetta (LI) e un casolare
con lo stesso nome a Campiglia Marittima (LI).
Corridore ha una
diversa accezione, meno comune, sinonimo di corridoio;
qui, evidentemente, non ci si riferisce a quelli delle case
o di altri edifici, ma ad un corridoio come striscia di
territorio incuneata tra due stati o due paesi o due
proprietà.
Un podere o un campo, anche
solo una striscia di terreno (come a volte accade) che
corre tra un’ansa di un torrente e la strada, oppure tra
questa e un altro campo o podere, ecc.
In questo senso corridore
si inserirebbe in quel gruppo di microtoponimi di senso
spaziale e con finalità di delimitazione, come Imbocco,
Finale, Portone (forse, nel senso di
“ingresso”, “accesso”), ecc.
|

Guazzino, zona del Corridore |
CUPA (via) (podere) (Bettolle)
Cupa è voce latina, significa “tina”, “tino”, “botte,
barile”, ed è diffuso, in varie regioni, come nome di luogo
e appellativo geografico.
Da confrontare con l’accezione
in italiano di cupa: “strada infossata”, “callaia”,
“gola”, “vallea”.
Nella toponomastica toscana:
Cala cupa all’Isola del Giglio (GR), Ricupo,
fosso, a Scansano (GR), Cupo e rio Cupetto a
Campagnatico (GR), Valle-cupa a Piancastagnaio (SI).
Le cupe che incontriamo nei nostri paesi fanno
pensare appunto a strade infossate, gole, secondo il
senso del latino cupa, “tina”.
Nel Dizionario di italiano
troviamo l’aggettivo cupo, e, in una delle accezioni
che a noi qui interessano, indica: “profondo, molto
incassato” (es. pozzo cupo, valle cupa). Come voce regionale
significa “fondo, concavo”. In quanto termine antico – ora
desueto – indicava una “profondità buia” e viene riportato
un nobile esempio: Dante nella Divina Commedia, Inferno,
VII,: “Non è sanza ragion l’andare al cupo”.
|

Bettolle, zona via Cupa |
|
|
DIACCETO (via) (Trequanda)
Diaccio in dialetto toscano significa “freddo”,
“ghiacciato”. È una forma alterata di “ghiaccio”, comune
al popolo toscano, allo stesso modo che diacere
per giacere o diacinto per giacinto.
Diacceto ha anche
il senso di ‘luogo aperto dove può molto il freddo’.
Ancora, diaccio in
mineralogia è una macchia bianchiccia e diafana come il
ghiaccio che si scorge in alcune pietre e marmi.
Si potrebbe anche pensare
che anticamente qui aveva sede un luogo di
refrigerazione naturale (pratica usata in tutta Italia),
come potrebbe essere una raccolta di ghiaccio o di neve,
usata, un tempo, per la conservazione dei cibi. Il
toponimo, che proviene dal latino glaciem, si
ritrova, in varie forme, in altre località:
Diaccialetti ad Abbadia S. Salvatore (SI) e Manciano
(GR), Diaccialone a Scansano (GR), Il Diaccino
a Castiglione della Pescaia (GR), Diaccione a
Massa Marittima (GR) e ancora (con la radice ghiacc-) in
Ghiacciale a Montalcino (SI), Ghiaccialone
a Magliano (GR), e Ghiaccione a Guardistallo
(PI).
In provincia di Lucca, nel
comune di Capannori, c’è Diacceto che viene così
interpretata: “La disposizione longitudinale, da nord
a sud, del Capannorese, forma una sorta di rettangolo
ristretto al centro e con i lati minori disposti da est
a ovest. (…) Quella settentrionale è esposta al sole e
secondo le caratteristiche della toponomastica lucchese
può essere chiamata «calda» o «caldana». Quella
meridionale invece è dominata per la maggior parte del
giorno dall’ombra prodotta dai Monti Pisani, ed è quindi
definibile «fredda» o «freddana». (…)
Lo attesta
l’inequivocabile denominazione di Diacceto,
Diaccio e Ghiaccetto che hanno tre diverse
località”
|

Trequanda |
|
|
ESSE SECCO (o Essesecco) (Bettolle) È un
podere nei pressi della Real Fattoria. È considerata una
delle più belle costruzioni rurali edificate nella
Valdichiana, con il caratteristico loggiato e gli
edifici accessori a delimitazione dell’aia.
Il toponimo potrebbe avere origine da un antico nome
personale, Esse, etrusco Esi, latino
Essenius.
Esse è anche il nome di due corsi d’acqua in Val
di Chiana. Il torrente Esse si versa nel
Clanis. Esse secco in quanto non più
esistente, prosciugato? Oppure perché soggetto a periodi
di secca durante la stagione estiva? A Firenze c’è una
località chiamata Poggio Secco.
Il tema secco, dal latino siccum, ricorre
a volte in toponomastica, ad es. Borro-secco a
Rosignano (LI), Botro-secco a Montieri (GR),
Cerri-secchi, podere a Massa Marittima (GR),Costa-sicca,
presso Siena, Poggio-secco a Cetona (SI), e
ancora: Rigo- secco, Rio-secco,
Ri-secco, Seccheto, Secchieta, ecc.
|

Bettolle, leopoldina
Podere Esse Secco |
|
|
FARNETELLA
(anticamente, in alcuni documenti, citata come
Farnatella) Fu comunello autonomo, prima
di venire aggregato al comune di Sinalunga nel 1778.
I vari toponimi come
Farneta, Farnetella, Farneto,
ecc., che incontriamo in Toscana, ma anche in varie
regioni italiane, possono facilmente essere
ricondotti alla radice latina farnum, in
italiano “farnia”, specie di quercia ghiandifera, ad
indicare la presenza nel territorio di queste
vegetazioni.
Qualche esempio:
Farna a Manciano (GR), Farneta a
Pomarance (PI), Farnese ad Asciano,
Farnieto a Monticiano (SI), Farniola a
Civitella196. “Farneto è un f itonimo
collettivo, dal latino farneus (frassino,
farnia), col suffisso -etum”.
G. Losi, Guida
del viaggiatore - Nel proseguimento della Strada
Ferrata da Siena a Sinalunga, Siena 1860. “Il
Paesello di Farnetella, antico Feudo, che passato
dal dominio dei Conti della Scialenga sotto il
Comune di Siena, fu per ordine di questo fatto
demolire nel 1271, perché troppo spesso, per essere
posto nella frontiera del Contado Senese, dava asilo
ai Fuoriusciti di contrario partito”.
“Il toponimo
Farnetella trae origine, probabilmente da
farnia, albero della famiglia della quercia, ma
a foglie più larghe, e di minore sviluppo. La farnia
cresce in grande quantità presso Farnetella,
specialmente a Castelvecchio.
Lo stemma di
Farnetella è rappresentato da una farnia in sfondo
rosso”.
|

Farnetella |
FOENNA
(torrente) Lungo circa 37 chilometri, di cui 20 nel
territorio del comune di Sinalunga, e gli altri tra
Foiano, Lucignano, Monte San Savino e Rapolano.
In alcuni documenti è
scritto Fuenna e in alcune carte anche
Fenna.
La valle del torrente
Foenna percorre tutto il territorio comunale
in senso longitudinale, partendo dalle colline di
Rigomagno fino all’immissione nel Canale Maestro
della Chiana.
Il Foenna ruppe gli
argini provocando gravi allagamenti in diversi
periodi: negli anni 1667, 1758, 1788 e 1896. Questo
problema si è verificato anche in tempi recenti.
Qualche considerazione
sull’origine e il significato dell’idronimo (nome di
fiume). “I nomi dei corsi d’acqua di norma sono
quelli che più tenacemente si conservano, tanto che
non pochi fiumi e torrenti toscani sono
riconducibili ad etimi etruschi o addirittura a basi
mediterranee”. Pare che il toponimo Foenna
derivi da un nome etrusco, Fuvìnna, da
Puina, diventato Foenius in latino, e di
questo ne è convinto il Pieri, che afferma: “Il
dittongo non può essere antico, e dovè risultare dal
dileguo di consonante mediana (se no, avremmo Fenna);
e non pare ammissibile perciò la diretta connessione
a Foenius, secondo proponeva lo Schulze. Il quale
non bene a Fuvius vorrebbe connetter Fojano, che
senza dubbio continua l’agg. di Furius, cioè Furianu”.
In un antico
documento, ( Leonardo Da Vinci: veduta a volo
d’uccello della Valdichiana, 1503, Windsor Royal
Library) su cui tanto si è discusso, anche in
campo toponomastico, Leonardo tratta di questo nome
di torrente, chiamandolo Fenna. E non è
chiaro se si tratti di un errore o meno.
|

Bettolle. Torrente
Foenna nella zona Esse Secco |
FOENNELLA
Podere Foennella assume il nome da Foennella
(diminutivo di Foenna, torrente della zona). Il
Foennella è un lago che certamente ha un legame
stretto con il torrente.
|

Torrita di Siena,
leopoldina del Podere Foennella |
FRATTA La
Fratta: “bellissima fattoria con annessi
agricoli grandiosi che si rifanno, nella struttura,
alla villa padronale disegnata da Baldassarre
Peruzzi nel Cinquecento.
Molto bello il
giardino all’italiana e la chiesetta, all’interno
della quale sono conservati pregevoli affreschi del
Sodoma.
L’origine della
fattoria è però molto più antica ed ha visto
numerose grandi famiglie succedersi nel tempo, tra
queste anche la famiglia del famoso Ghino di Tacco
che qui nacque”.
“La prima notizia
certa riferita alla Fratta risale al 1208”.
In generale il termine
Fratta deriva dal latino fracta,
‘(cose) rotte’, participio passato di frangere,
spezzare, dal greco frakte / fragma,
chiusa, e questo da frattein / frassein,
“assiepare, circondare”.
Si tratta di una
Siepe o Macchia naturale, ma in questo
senso non è di uso comune. Piuttosto è usato nel
senso di Luogo, per lo più rotto o scosceso,
intricato di pruni e altri sterpi e arbusti, che lo
rendono di difficile accesso o impraticabile.
“L’insediamento
originario, composto dal palazzo a pianta pressoché
quadrata, dal cortile con pozzo, dalla cappella e
dal giardino delimitato da muro di cinta e preceduto
da viale di accesso alberato, ripropone un modello
iconografico tipico delle ville rinascimentali del
senese di ascendenza peruzziana, modello questo che
si conservò inalterato anche nei secoli
successivi”224.
“La Fratta è
formata oltre che dagli edifici padronali sopra
descritti da numerosi ed ampi fabbricati adibiti
alle varie funzioni della vasta tenuta agricola che
i Gori Pannilini vi istituirono. Gran parte di
questi gravitano tutti attorno alla villa o sono
dislocati nel sito del vicino ed antico borgo
medievale della Fratta documentato fin dal secolo
XII come possesso dei Pecorai o Monaceschi che
dettero i natali al noto condottiero Ghino di Tacco.
Precise indicazioni
sullo sviluppo della tenuta agricola, che sembra
avvenuto nel corso del XVII secolo, sono fornite dal
Gherardini (A.S.S., ms. D.82 c. 210-211) il quale
nel 1676 scriveva che la tenuta della Fratta, «consiste
in venti poderi, diciassette dei quali sono sotto la
cura spirituale della Collegiata di San Martino e di
San Costanzo a Torrita e tre sotto la cura di S.
Lucia e della Pieve di Sinalunga.» Diversamente
nella denunzia della proprietà fondiaria del 1692
risultano attinenti della tenuta soltanto
quattordici poderi intestati ad Augusto Gori (S.
Pietro, S. Giacomo Minore, S. Giovanni, S. Tommaso,
S. Bartolomeo, S. Andrea, S. Giacomo Maggiore, S.
Mattia, S. Filippo, Redentore, S. Simone, S. Maria e
S. Paolo) mentre in nota all’elenco si dice che
questa famiglia possedeva nel 1746 anche i poderi S.
Mattia e Portone.
Verso la metà del
secolo successivo lo storico Pecci conferma
l’esistenza dei venti poderi ed aggiunge che «dodici
di quei poderi, nominati col nome ciascuno di uno de
dodici Apostoli, formano tutto il villaggio...»
(A.S.S., ms. D. 69, c. 156).
Questi ultimi fino a
qualche tempo fa erano identificati sui prospetti
dalle formelle scolpite raffiguranti appunto i Santi
Apostoli, ed oggi purtroppo scomparse (ne resta una
soltanto con l’immagine di S. Maria murata
all’esterno).
|

Tenuta la Fratta |
|

La Fratta, la villa |
FRATTICCIOLA
(Bettolle) Diminutivo di fratta. Toponimo unico nel
senese. Il Podere prendeva il nome dalla località,
tutt'ora esistente, il cui toponimo evoca
chiaramente il vezzeggiativo di fratta.
Probabilmente si
voleva distinguerlo dalla maggiore e più nota
Fratta.
|

Podere Fratticciola |
FUGA - (Podere
della Fuga) [vi è anche "Fuga di Sotto" e "La Nuova
Fuga"] In passato in alcuni documenti si trovava
anche la forma grafica fugga. E raro, solo 5
casi nella provincia, di cui uno al plurale Fughe.
Fugga è una
forma antica della parola fuga, come attesta il
Vocabolario della Crusca. Può essere correlato alla
parola foga, 'impeto', riferito ad esempio al
soffiare del vento.
In questo campo
semantico il Pieri interpreta il toponimo Futa,
il Passo della Futa, il Monte della Futa.
Egli vede Futa
come forma abbreviata (sincope) del latino fugita
> fu(gi)ta, e pensa alla violenza dei venti
della zona dell'Appennino in cui vi è la Futa.
Sostiene questa tesi
anche Carla Marcato, uno dei maggiori studiosi di
linguistica e toponomastica in Italia, nel
Dizionario di Toponomastica, alla voce Passo
della Futa.
Ha anche un'accezione letteraria, antica, come
ripidità.
Una qualche traccia di
questi termini si ritrova anche nel dialetto
chianino, ad es. nell'espressione fogàssi,
'buttarsi con foga su qualcosa'.
Infine, una delle
accezioni della parola fuga è la 'fuoriuscita
rapida e copiosa di un fluido da una conduttura'; in
tal senso è da accostare ai termini sfogo e
scolo, quest'ultimo presente a volte nelle
antiche carte e piante di un territorio, da
avvicinare al significato di canale di scolo,
e ancora fossato per lo scolo delle acque,
liquidi, ecc.
Credo che il
significato di fugga sia proprio nel campo
semantico di scarico, scolo, sfogo, via di
uscita, via di fuga, come si può desumere anche
da analoghi antichi toponimi sinalunghesi, come ad
es. Baregno o Rifiuto del Mulino di
Montemartino. I mulini (molto numerosi a quel
tempo) scaricavano i materiali e liquidi di risulta
delle lavorazioni in alcuni punti di fossi e
vari corsi d'acqua minori.
|

Torrione dei Poderi
della Fuga |
|

Leopoldina del Podere
Fuga II |
|
|
GALEGNO
Torrente e nome di una valle. La piccola valle del
torrente Galegno, tributario del torrente Foenna,
separa la dorsale collinare di Collalto da
l'Amorosa.
Lungo nove chilometri,
i comuni interessati sono Sinalunga e Trequanda. Il
Pieri ritiene che gli idronimi Galegno e
Galegnolo derivino dall'antico nome latino
Galenius.
|

Torrente Galegno (in
basso) nella zona di congiunzione con il
Torrente Foenna |
GORGO (podere)
(Bettolle) Gorgo: è un idronimo (nome
relativo a corsi d’acqua): è il punto in cui il
letto di un fiume o di un torrente si abbassa
improvvisamente, quasi a formare un piccolo pozzo;
per estensione: il vortice, il mulinello che l’acqua
forma in quel punto.
Talora con gorgo
si indicano anche quelle “cavità puteiformi” piene
di acque sorgive.
In senso letterario,
poetico, gorgo è sinonimo di fiume: “E tu,
corrente e chiaro gorgo” (Petrarca, Canzoniere).
Dal latino gurgu(m),
gola, voragine. Gorga: gola, fosso stretto e
profondo.
In provincia di Siena
non è molto diffuso: ricorre quattro volte: oltre al
toponimo sinalunghese c’è Fosso la Gorga a
Monteroni d’Arbia, le Gorghe a Rapolano e
Ponte alle Gorghe a Trequanda. In Toscana
troviamo: Sorgente del Gorgo a Campiglia
Marittima (LI), Podere del Gorgo a Livorno,
Le Gorgacce a S. Fiora (GR), Gurgo
presso Bibbona (LI), Pian del Gorgo a
Capoliveri (Elba) (LI), Gorgoli a Livorno e
Gorgacce a Sorano (GR).
“Al latino volgare
gurgus «vortice del fiume», da cui l’italiano
gorgo, vanno riferiti i vari Gorgo, con gli
alterati Gorgone e Gorzone”.
|

Bettolle, podere Il Gorgo |
GUAZZINO
Frazione di Sinalunga. Fu un comune autonomo fino
all’aggregazione definitiva al comune di Sinalunga
nel 1778.
Alcune ipotesi
sull’origine del nome:
1) Una dotta
interpretazione tratta dal Dizionario del Repetti:
“Il vocabolo di Guazzino potrebbe esser derivato dai
possessi che ebbe costà un Guazzino di
Montepulciano, del di cui figlio (Duccio di
Guazzino) è fatta menzione in un istrumento del 19
febbraio dell’anno 1310, quando egli a nome della
comunità di Montepulciano ricevè in deposito da
Guglielmo dei Cavalieri del Pecora mille fiorini
d’oro per restituirgli ad ogni sua richiesta”.
Sappiamo, in toponomastica, che a volte il nome di
un paese deriva da un personaggio, talora illustre,
o da una famiglia che lo fondò o possedette, nel
corso del tempo; sappiamo però che a volte è
capitato il contrario, e cioè che una famiglia o un
signore abbiano assunto il nome dal luogo in cui
operavano. Sono possibili, quindi, anche nel caso di
Guazzino, entrambe le ipotesi.
2) Potrebbe
trattarsi di un diminutivo di Guazzo, che,
anche in italiano è acqua bassa, pantano; si
incontrano diversi toponimi con questa radice:
Guazzatoio, un podere a Trequanda, Guazzara
podere a Montalcino, Guazzerone a Chiusdino.
Potrebbe anche
derivare da una voce germanica o longobarda,
wazzer, acqua, da cui guazzo/ guazza, con
la nota trasformazione di w in gu.
Esempio: Guazzatoio (PT).
|

Guazzino - Festa delle
Rocche |
|
|
LAURETANA
(strada / via) Un tratto di questa importante via di
comunicazione attraversa anche il territorio di
Sinalunga.
È un’antica strada
etrusco-romana della Valdichiana che collegava
Cortona a Montepulciano e Siena.
Con l’impaludamento
della Valdichiana (IX secolo), dal percorso iniziale
si sviluppò la cosiddetta Via Lauretana, nata
per collegare Cortona a Montepulciano e Siena.
Il nome Lauretana
(di probabile attribuzione settecentesca) deriva dal
toponimo Loreto, localizzato nella piana
sotto Cortona, nella zona del Sodo e che dà
il nome anche al fosso locale. È da qui che partiva
il primo ramo di questa strada che Emanuele Repetti
nel suo Dizionario chiamò Antica Lauretana
distinguendola dalla più importante Strada Regia
Lauretana.
La primitiva via, che
con molte probabilità esisteva già in epoca romana
come uno dei tanti diverticoli della Via Cassia
e abbandonata per forza maggiore dopo l’allagamento
della valle, passava per Fratta, Santa Caterina,
Fratticciola, Creti, Ponti di Cortona, Foiano della
Chiana, Lucignano, Rigomagno, San Gimignanello,
Asciano e terminava a Siena.
Abbiamo visto che
lauretana deriva dal paese Loreto.
Aggiungiamo che, a sua volta, il nome di questo
centro, come nella più celebre Loreto (AN),
proviene dal fitonimo (nome di pianta) laurum,
‘alloro’, con il suffisso collettivo -etum;
come nel latino Lauretum, bosco di lauri
sull’Aventino.
|

Crete Senesi - Via
Lauretana |
|
|
MADONNA DI GALLO
(Rigaiolo)
Località in cui vi è la piccola chiesa della Madonna
della Consolazione detta Madonna di Gallo.
Per Gallo:
varie ipotesi:
1)
Potrebbe essere una derivazione (con storpiatura
popolare, dialettale o evoluzione del nome) da
gualdo: “voce toponimica, deriva dal longobardo
wald, “bosco”, ed è assai frequente come nome
locale nel territorio interessato dall’occupazione
dei Longobardi. Il termine è attestato anche come
appellativo nelle carte medievali, spesso
nell’accezione di “dominio”, cioè un insieme di
terreni coltivati o non, con boschi o meno”.
2) Don A.
Maroni spiega che il toponimo deriva dal cognome
(Gallo o de Gallo) di una famiglia della zona (è
attestato un de Gallo Antonio, nei registri
battesimali della Pieve di Sinalunga, nel 1551) che
l'avrebbe eretta e ne avrebbe cura nel corso del
tempo, come segno di fede e devozione mariana.
3) Si confronti
Capo Gallo, estremità della costa
settentrionale della Sicilia, in cui uno sperone
roccioso per la sua forma è paragonato a un gallo,
da qui deriva il nome. Qualcosa di simile per il
toponimo sinalunghese?
La Chiesa della
Madonna della Consolazione, detta volgarmente di
Gallo, situata a Rigaiolo (frazione di
Sinalunga) versa ormai in uno stato precario. Il
tetto della struttura è praticamente crollato
esponendo così l’affresco presente nell’abside alle
intemperie e a tutti quegli agenti dannosi per
l’opera.
Il toponimo "Madonna
di Gallo" è ricordato già nel 1686 in un
documento che autorizza "la Fiera Libera alla
Madonna di Gallo per i tre giorni 14,15,16 del mese
di Agosto"
L’edificio, voluto
dal Vescovo di Grosseto Giò Battista de Gori
Pannellini nel 1650 d.C. e che nel corso dei secoli
è stato anche adibito a lazzaretto, fu venduto dalla
Curia Vescovile ad un’agenzia privata qualche anno
fa, per la scarsità di fedeli e per i costi alti per
il restauro.
Il territorio della
Valdichiana è ricco di queste piccole Chiese, che
all’insaputa di molti, contengono vere e proprie
opere d’arte spesso trascurate e senza tutele
sufficienti.
|

Rigaiolo, chiesa Madonna di Gallo |
MONTEMARTINO
(Guazzino) L’origine potrebbe essere nel nome
personale Martinus che concorre in diversi
toponimi come seconda componente, dove la prima
parte invece denota un aspetto del territorio, ad
es. Fontemartino a Pomarance (PI),
Poggiomartino a Roccalbegna (GR),
Vallemartina a Manciano (GR) e ancora Monte
Martini a Gaiole, Colle Martini a San
Giovanni d’Asso e Cella Martini a Chiusdino
(SI).
|

Guazzino, fornaci di laterizi
Montemartino |
MULINACCIO - (e
Mulinaccio II) Nella grafia Mulinaccio è un
Hapax, caso unico nel contesto della toponomastica
senese.
Nella forma
Molinaccio ricorre 20 volte. Col suffisso
peggiorativo -accio, spesso usato in Toscana,
richiama il Mulino (più di frequente
Molino) elemento molto comune, presente in 120
casi nel Senese; ed è ben comprensibile se si pensa
all'importanza dei mulini in passato e ai vari usi
necessari alle comunità.
MULINACCIO -
Podere I e II - La casa di questo podere si presenta
nella pianta del Catasto Leopoldino composto da due
abitazioni, ognuna delle quali è costituita da due
interassi di vani, oltre un corpo antistante, il
tipico portico scala-loggia che caratterizza queste
case coloniche.
All'interno, i muri trasversali sono sostituiti da
archi per rendere i vani (stalle) un unico ambiente.
Un quarto della superficie del pianterreno (due vani
uniti da un arco) erano probabilmente destinati a
tinaia-cantina, poiché non vi è segnata la
mangiatoia come negli altri vani. Il portico era
caratterizzato da un grande ingresso ad arco,
probabilmente a tutto sesto. L'arco era spostato
verso l'estremità, in modo da dare spazio ad una
finestrina.
Dall'esterno, la scala conduceva al primo piano
all'abitazione, preceduta, come sempre, dalla loggia
illuminata da un arco della medesima ampiezza di
quello del pianterreno (m. 1,75).
Nella sezione del Catasto non è presente la
piccionaia.
|

Torrita, Leopoldina
del Podere Mulinaccio |
MUSARONE (fosso
e podere) (Bettolle) Il ‘fosso’, cioè un corso
d’acqua, è lungo tre chilometri, tutti nel
territorio di Sinalunga.
Poi c’è un podere con
il medesimo nome, probabilmente nel terreno
attraversato da questo torrente.
C’è il podere
Musarone anche a Cortona (AR).
Il Pieri mette questo
toponimo tra i nomi locali di origine oscura e
incerta. Cominciamo col dire che il termine è raro,
anzi, unico, almeno nella provincia di Siena.
Aggiungiamo che è piuttosto insolito e alquanto
misterioso.
Tentiamo qualche cauta
congettura:
1) Potrebbe
essere accostato alla voce dialettale musa
(di cui sarebbe un accrescitivo) che in alcune
accezioni indica la ‘treggia’, arnese che serve per
trascinare materiali (legna, fieno o altro).
2) Potrebbe
essere un accrescitivo di musara, “musara
della cavezza”, termine usato per indicare
l’aggancio delle briglie, ad esempio ad un cavallo.
3) Forse è da accostare a musarola,
dizione popolare (così come muserola) di
museruola, l’arnese a forma di gabbia tronca
costituito da fili di ferro o strisce di cuoi
intrecciate, che si pone al muso dei cani perché non
mordano o degli animali da lavoro perché non
mangino.
4) Potrebbe
essere un antico soprannome, attribuito ad una
persona che viveva in questa località, originato dal
suo carattere e atteggiamento di musare, voce
antica per “oziare, perder tempo, stare a guardare
con meraviglia o curiosità”. (Per inciso: seppur non
comune, si dice anche di animali che stanno col muso
levato).
5) Da
connettere con musàssi, voce chianina per
“fronteggiarsi muso a muso”, detto di animali, ma,
per estensione, anche di persone. Anche in questo
senso potrebbe essere un nomignolo, un soprannome.
6) Musa
(aferesi di ammusa) è voce di alcuni dialetti
che indica un luogo sabbioso.
7) Se non pare
troppo azzardata o fantasiosa l’ipotesi, musarone
potrebbe relazionarsi al termine zoologico
musaragno, il “toporagno”, nome derivato dalla
locuzione latina mus araneus (‘topo’ simile
al ‘ragno’ [per le sue dimensioni]), che come si
vede è molto simile a musarone, di cui potrebbe
essere una storpiatura popolare. Forse, un tempo, in
questa zona vi erano animali di questo tipo.
8) In altre
regioni si trovano toponimi come Torre Musara e
Rocca Musara o Musarra, che non sapremo
dire se abbiano o possano avere qualche attinenza
col toponimo sinalunghese.
|

Bettolle, imbocco del
fosso Musarone nel torrente Foenna |
|
|
ORSINO (Rigomagno)
Alcune ipotesi:
1) Potrebbe
essere messo in relazione con un antico nome
personale: Ursina, etrusco Ursmini;
latino Ursenius, da cui, ad es., il toponimo
Orsèna (Fosso d’-) che si trova a Pienza
(SI). O anche Ursius, anch’esso antico nome
latino. Vi sono documenti che riportano una
Ursina presso Montefollonico (Torrita, Siena).
2) “Per
indicare l’appellativo Ursinensis, si usano
(nel Martirologio Geronimiano, ndr) i
vocaboli: ad Ursum, Ursi, Ursicini
(…). Con i vocaboli Paletrina e Ursinensis
si è voluta ricordare la presenza dei templi di
Falater e di Ursina, cioè di Giove e di
Giunone, dèi protettori della colonia, che dovevano
avere il loro templio nel vicus Falatrine,
nella zona di Poggio Baldino”.
3) Vi è un
documento che cita Francesco Orsino: “Il 6 ottobre
1357 accadde fra Sinalunga e Torrita un
combattimento nel quale dall’esercito senese,
comandato da Francesco Orsino, fu sconfitta la
Compagnia di ventura del Cappello, composta di
Brettoni; e comandata da Niccolò da Montefeltro
conte di Urbino, che restò prigioniero con altri
Capitani e con trecento uomini d’arme e mille
pedoni; i quali tutti furono condotti legati a
Sinalunga. Questo fatto è dipinto nella sala del
palazzo del Potestà di Siena”.
4) In
quell’epoca vi era anche il cardinale Orsino, che
viene citato in alcuni documenti inerenti la storia
di Siena e di Sinalunga. Comunque, il nome Orsino
e anche il cognome, sono citati in diversi periodi
della storia di Siena e di Sinalunga. Più banalmente
potrebbe trattarsi di un antico titolare di un fondo
nella zona.
|

Rigomagno, panorama |
|
|
PADULECCHIE -
A volte si incontra
anche la forma grafica di Padolecchia. Si
tratta di un caso unico in tutta la provincia.
Alla radice vi è i
termine padule , che ricorre (come forma-base
di un toponimo) altre quattro volte nel senese.
Padule è una
variante toscana di palude (forse per un
processo linguistico detto "metatesi" per cui si
invertono due lettere o una sillaba).
Da notare che il
diminutivo di padule è paduletto/paduletta,
che non è molto dissimile a padulecchie.
Quel suffisso
acchia/ecchie, potrebbe essere un riflesso di un
incrocio con parole tipo catapecchia, che
anticamente indicava un "luogo selvatico, sterile".
Più in genere il tema
padule / palude, ecc., richiama il periodo in
cui una parte della Valdichiana era impaludata.
|

Torrita di Siena, zona
delle Padulecchie |
PANNELLINA - (Pannellina
I, II) In qualche caso si trova anche la
denominazione "Podere la Pannellina".
Caso unico nella
provincia. Può forse essere spiegato nel seguente
modo.
1) Diminutivo e
in versione femminile di panno, dal latino pannu(m),
coi diminutivi pannellu(m) e panniculu(m),
a indicare un lembo sottile di terra. Riguardo alla
forma femminile (Pannellina) si possono
aggiungere due considerazioni: A. In Italiano antico
esisteva pana, variante di pano
(panno). B. potrebbe trattarsi di un toscanismo.
2) Un confronto
con un toponimo simile, Panni, comune in
provincia di Foggia.
Una delle etimologie
possibili è dal latino pandus, "curvo,
piegato", riferito a qualche elemento geomorfico.
Ancora riguardo alla
forma femminile si può aggiungere che non è raro in
Toscana questo uso, come si può vedere in vari casi,
ad es. in Poderìna (Montalcino; Guazzino)
dove incontriamo, come nel nostro toponimo, sia il
diminutivo che la desinenza femminile.
|

Podere I e II della
Pannellina |
PORTICCIOLO -
Testimoni dell'inizio della palude, rimangono i
poderi Porticciolo 1° e Porticciolo 2°, chiari
toponimi che indicano dove si trovassero gli
attracchi delle barche per la pesca e il trasporto
nel lago.
(Bettolle) Diminutivo
di porto. Piccolo luogo sulla riva di un corso
d’acqua per riparo e attività di imbarcazioni. Dal
latino portu(m), propriamente ‘entrata,
passaggio’, della stessa radice di porta.
“La fertile pianura
sottostante, quella Valdichiana famosa per aver
rifornito di grano la flotta romana in partenza per
Cartagine, si stava impaludando. Le delicate
canalizzazioni etrusche erano ormai saltate e, di lì
a poco, la valle si sarebbe trasformata in un
immenso acquitrino. A riprova dell’estensione della
palude, sono giunte fino a noi varie località – in
tutta la valle – con il nome di «Porto»”
.
|

Montepulciano, zona
dei Poderi del Porticciolo |
PORTO Sono tre
i toponimi sinalunghesi che richiamano il tema del
porto ed evocano la navigabilità dei fiumi o
l’esistenza in passato di zone di palude.
“Le terre che
emergevano dalle acque venivano anche chiamate
Isole, e ad esse si accedeva partendo da
Porto”.
“La ricchezza di
queste famiglie derivava da un sapiente sfruttamento
agricolo della fertilissima Val di Chiana e
verosimilmente delle stesse zone acquitrinose
ricordate da Strabone per la coltivazione del
papiro; ulteriore fonte di arricchimento doveva
venire dalla pesca. (…)
“Fonti documentarie di
età medievale testimoniano come il fiume Clanis
fosse ancora navigabile in più punti, tra Chiusi e
la zona di Bettolle: nel 1325 venne deliberata dagli
Statutari di Cortona la costruzione di una nave (…)
Inoltre si doveva
provvedere ad alcuni restauri al porto di Fasciano
(…) Il Chierici ha proposto di identificare questo
approdo con la località Porto (250 slm.) nel
territorio di Sinalunga”.
“Questa navigazione ha
lasciato tracce evidenti nei toponimi «Porto», come
Portovecchio in Versilia, Porto sul margine nord-est
dei Monti Pisani, i sei Porti indicati nelle vecchie
carte topografiche dell’IGM intorno al padule di
Fucecchio, Porto e Porticciolo in Valdichiana”
|

Bettolle, Via del
Porto - zona di Rotone |
PORTO VECCHIO -
Hapax, unico caso nel Senese. Anche gli altri
toponimi sul tema "porto" son rari, solo 5
occorrenze.
Scrive Giulio Paolucci
in Sinalunga e Bettolle. Due centri etruschi della
Valdichiana:
«A nord le ricche sepolture di Quercia Caffera
dovevano sorgere lungo un itinerario che collegava
Bettolle ai centri di Foiano e Marciano, dal quale
probabilmente si diramava un diverticolo che
scendeva verso il fiume, dove appare ragionevole
ipotizzare l'esistenza di un approdo e di un
traghetto, che forse possiamo restituire in località
Porto Vecchio».
Riccardo Ambrosini in Lucca e il suo
territorio afferma: «Le terre che emergevano
dalle acque venivano anche chiamate Isole, e ad esse
si accedeva partendo da Porto».
Landò Bortolotti, La formazione dell'identità
regionale: «Questa navigazione ha lasciato
tracce evidenti nei toponimi «Porto», come
Portovecchio in Versilia, Porto sul margine nord-est
dei Monti Pisani, i sei Porti indicati nelle vecchie
carte topografiche dell'IGM intorno al padule di
Fucecchio, Porto e Porticciolo in Valdichiana».
|

Bettolle, Leopoldina
del Podere Porto Vecchio |
PRATA (anche
via, traversa di via Trento) Uno dei nove rioni in
cui si articola Sinalunga.
Termine antico per
indicare i prati, si diceva anche le
pràtora.
Prato: tratto
di terreno coperto d’erba, spontanea o seminata.
Propriamente prata è il plurale di pratum,
prato.
Ricorre spesso in
toponomastica, ad es. la città di Prato, e
ancora: Pratella, Pratiglione,
Pratola, Pratomagno, Pratovecchio.
A proposito del
toponimo sinalunghese citiamo questo brano che
racconta le opere di bonifica delle zone paludose: “Il
problema centrale riguardava l’area dei “Prati di
Sinalunga” (la zona che oggi si chiama Le Prata),
che all’epoca era quasi sempre impaludata perché la
Foenna, avendo gli argini più alti della pianura,
non era in grado di riceverne l’acqua.
Ai margini di questo
problema c’era anche la questione del molino di
Monte Martino (di proprietà della comunità), nei
pressi dei Prati di Sinalunga, che vedeva ridursi
sempre più la sua capacità di far ruotare le macine
a causa dell’innalzamento del letto della Foenna”.
Giovan Battista Del
Corto nel suo libro Storia della Val di Chiana
cita questo luogo:
“Nell’Archivio di
Stato Senese, vi ha un volume a parte, manoscritto,
intitolato Livellazione del piano di Sinalunga,
contenente una relazione di Fabiano Fabiani in data
17 luglio 1742 ed una pianta. Nella relazione è
studiato anche il modo di liberare dalle inondazioni
e dall’impaludamento quel tratto di piano
sinalunghese che chiamasi Prati o Prata, e si parla
pure delle condizioni della Foenna, dell’elevazione
del suo alveo, de’ suoi interrimenti, delle sue
arginature composte di terreni poco resistenti al
peso delle acque”.
|

Sinalunga - Le Prata |
PRESA -
L'origine della parola (usata in questo caso come
toponimo) è presa, "appezzamento di terreno",
dal latino prehendere.
Presa esprime il
concetto della suddivisione dei terreni (le "prese"
appunto) avvenuta per vendita, per rotazione agraria
o per bonifica.
Nel dialetto senese la
parola presa indica un "appezzamento di
terreno di buona misura" Anche negli antichi
contratti si scriveva ad es.: Pianta d'una presa di
terreno boschivo denominata..."
Esiste, in altra zona,
anche il toponimo Preselle, a indicare il
diminutivo.
|

Bettolle - presa di
terra delimitata da testucchi |
PRESELLE -
Torrita - Il toponimo è formato dal plurale e
dal diminutivo del termine presa,
“appezzamento di terreno”, dal latino prehendere.
Presa esprime il concetto della suddivisione dei
terreni (le “prese”, appunto) avvenuta per
vendita, per rotazione agraria, per bonifica, ecc.
Troviamo, al singolare. C’è anche la variante
Presaccia, ad esempio a Rapolano (SI), che suona
come accrescitivo, o meglio, come una sorta di
“dispregiativo”, con il tipico suffisso toscano -accio.
|

Torrita di Siena -
zona preselle |
|
|
QUERCE CAFFERA
(podere) (Bisciano / Bettolle) Talora la
denominazione del luogo è al singolare, Quercia
Caffera (ma sappiamo che in toscano il singolare
di quercia è reso con querce).
Nel 1834, presso
questo podere furono scoperti alcuni resti di tombe
ed edifici etruschi risalenti al IV e III sec. a.C.
Alcune ipotesi per
spiegare l’enigmatico termine caffera.
1) Caffera
è anche una delle varianti del cognome-base Caffo
e anche Càfaro.
2) Il
termine Caffera forse è da accostare
all’arabo kafir o kafr, ‘fosso, scavo,
luogo scavato’; questa radice si trova ad es. nel
siciliano càfuru, ‘vuoto, fracido, morbido’ e
nel calabrese càfaru, ‘cavità, buco’ e anche
‘burrone, solco profondo, ruscello’. Esiste il
torrente Càffaru (CS), e nella toponomastica
calabrese si incontra questa radice (con significato
anche di “vuoto dentro, tarlato”) in alcuni toponimi
come le contrade Cafarone, Cafurna,
Cafuru.
3) Càffaro
in agricoltura è una pasta o polvere
anticrittogamica.
4) Caffo
in toscano significa ‘dispari’ (dall’arabo kaff,
‘palmo della mano’).
5) Cafro
(dall’arabo kafir, ‘infedele’) era un termine
spregiativo con cui gli europei designavano le
popolazioni nere insediate nell’area sudorientale
dell’Africa.
6)
Potrebbe esserci una connessione con un particolare
tipo di quercia, nome scientifico Quercus
coccifera, dalla corteccia rossastra, usata tra
l’altro per tingere di rosso gli indumenti.
|

Bettolle - Loc.
Bisciano - Podere Querce Caffera |
|

Bettolle - Loc.
Bisciano - Podere Querce Caffera -
fronte |
|
|
REAL FATTORIA -
Bettolle - Fattoria storica appartenuta all’Ordine
dei Cavalieri di S. Stefano e ai Granduchi di
Toscana. Oggi villa nel centro storico di Bettolle.
Real in senso
di reale / regale, termine antico per
indicare cosa che per il suo essere, la sua qualità,
la sua importanza, è degno di un re.
In toponomastica
troviamo Realmonte (AG), che era Mons
regalis, Monte Regale, e ancora
Monreale (PA), anche questo con valore di
Monte regale.
“Al momento della
cessione dalle Regie Possessioni all’Ordine di Santo
Stefano, la fattoria viene indicata con la
denominazione di Torrita (o Turrita) (…) ma a
partire dalla seconda metà del Seicento, la stessa
fattoria viene sempre più spesso denominata
abbinando al nome di Torrita quello di Bettolle.
Piuttosto che di due
distinte fattorie (Torrita e Bettolle) si tratta di
un’unica azienda con doppia denominazione, dovuta
alla sua estensione a cavallo di entrambi i
territori. (…)
Invece nei decenni
successivi prevarrà la denominazione di Bettolle su
quella di Torrita: già nella pianta della fattoria
datata 1684, troviamo l’indicazione di Bettolle e da
allora in poi, per un processo di scivolamento
nominalistico, viene definitivamente indicata come
fattoria di Bettolle, ma si tratta sempre della
stessa azienda agraria che si espande sul territorio
in direzione di Bettolle a seguito ai lavori di
bonifica e regimazione delle acque del torrente
Foenna e per gli accorpamenti e nuovi acquisti,
effettuati dai ministri della Religione di Santo
Stefano.
Ancora oggi prevale la
denominazione di Fattoria di Bettolle, per indicare
le parti della fattoria acquistate nel 1864 dalla
famiglia Puccio e tuttora in possesso degli eredi”.
|

Bettolle - Palazzo di
Fattoria |
ROMITORIO
(Romitorio di Sopra e Romitorio di Sotto) (Scrofiano)
Romitorio, che sta per ‘eremitaggio, eremo’,
è derivato da romito, variante popolare di
eremita, persona che si ritira in solitudine per
dedicarsi alla ricerca della perfetta unione con
Dio, concentrandosi nella preghiera, contemplazione
e penitenza.
Eremo deriva
dal latino tardo eremu(m), dal greco
eremos, ‘solitario, deserto’.
In toponomastica
troviamo L’Ermèta ad Abbadia S. Salvatore,
Poggio Romito a Sovicille e Romito a
Roccastrada.
Identico al toponimo
sinalunghese, Romitorio, è a Castelnuovo
Berardenga.
Infine esistono anche
Romitello a Chiusdino (SI) e Romitelli
a Castiglione d’Orcia (SI).
Bartolomeo Gherardini
(Auditore Generale in Siena) Visita alle Terre dello
Stato Senese Vol. I C..
“Chiesa e
Romitorio di S. Pietro. Chiesa con il suo romitorio
sotto il titolo di S. Pietro in Vincolis, questa è
della Comunità, che a suo tempo elegge il romito, il
quale ha obbligo celebrarvi la festa titolare (la
quale, com’è noto, cade il 1º di Agosto) e gode un
pezzo di castagneto, una vignarella et alcune terre”.
In un poggio presso
Farnetella (l’Eremo della Bandita, chiamato da
tutti il Romitorio) viveva un misterioso
abitatore.
Il poggio anticamente
apparteneva al Comune di Farnetella e
successivamente di proprietà degli antichi signori
del castello.
Il Poggio dista circa
un chilometro da Farnetella e per arrivare occorre
attraversare una piccola viuzza con distese di
oliveti, vigne, piante, arbusti. La via continua con
una ripida salita e presso il colle del Romitorio si
biforca in due straduccie boschive, una che conduce
alla vetta del Romitorio e l’altra che continua per
i boschi, conosciuti tutti per Boschi della Bandita.
Il poggio è immerso
nel bosco fittissimo con alte querci, ed era abitato
da selvaggi e feroci animali, come cinghiali e lupi,
molto numerosi nel Medioevo nelle campagne toscane.
Nel 1400 circa, qui
abitava un uomo che alternava tutti i suoi giorni
fra silenzio e preghiere in solitudine. Era vestito
di sacco ed il suo nome era Alessio.
Alessio si rifugiò nel
bosco e fabbricò a sue spese una cappella ed una
capanna dove abitò per un lungo periodo finché non
morì.
Da come si apprende
nella Monografia Storico-Statutaria di Adolfo
Ferrari si dice che Alessio fosse di illustre e
ricchissima famiglia; cosa che spiegherebbe le spese
fatte da lui per la costruzione della cappella.
Alessio (si pensa che
appartenesse alla Comunità dei Frati Serviti
di Scrofiano) aveva scelto di vivere ritirato dagli
uomini e di vivere solo in mistica relazione con
Dio, perché diceva di averlo offeso.
Faceva penitenze,
diceva che doveva scontare gravi peccati e voleva da
Dio la misericordia e il perdono.
Nella cappelletta ogni
mattina celebrava la Messa per pochi pastori e
spesso veniva invitato dal Pievano di Farnetella per
celebrare la messa. Lasciava il suo tugurio ed
andava ad assistere le persone infelici e bisognose,
come nello Spedale di Farnetella.
Svolgeva innumerevoli
opere di pietà e di misericordia.
Da alcuni pastori
furono ritrovati resti di Alessio: una ciotola di
legno, con la quale egli attingeva l’acqua ad una
fonte lì vicina ed un oggetto appuntito di ferro che
serviva per punire il suo corpo e farsi disciplina.
Nel luogo dove sorgeva
la chiesa fu eretta una piccola costruzione dalla
Famiglia Ferrari e vi fu posta un’iscrizione: Si
trovano tuttora i resti della costruzione, anche se
in pessimo stato. Il poggio del Romitorio è
ogni anno una delle tappe della Visita delle
sette chiese della Processione del Venerdì Santo.
|

Scrofiano, panorama |
|
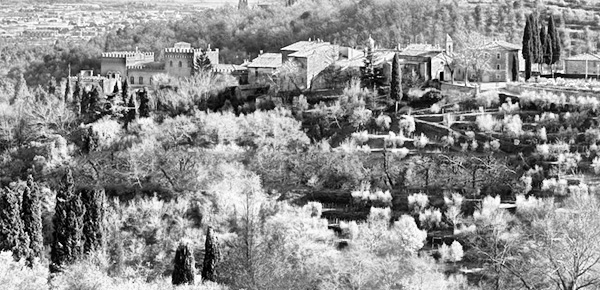
Farnetella, panorama |
ROTONE (Molino
del Rotone) (Bettolle) In questa località vi era un
mulino.
Il Pieri cita due
toponimi, Ruota a Capannori (LU) e Rota
a Seravezza (LU) e nota che essi sono in “relazione
a un mulino o altro opificio idraulico”.
“Ruota certamente deve
il suo nome alla presenza di mulini”. Anche nel
toponimo sinalunghese Rotone potrebbe esserci
questa etimologia.
Altre ipotesi:
1) Forse
rotone è da connettere al tema rota / ruota /
rotondo, con accrescitivo -one, con
allusione alla forma curva o rilevata di terreni,
dovuti ad esempio dall’ansa di un fiume, declivi o
terrazze, o con riferimento al mulino.
2) Forse
dal latino rupta, ‘via, sentiero’, con valore
accrescitivo.
3) Con un po’
di immaginazione, forse da accostare alla voce
dialettale toscana rota, cioè l’azione che
fanno le rotaiòle, le donne che durante la
castagnatura andavano lungo le strade a raccogliere
le castagne cadute, e, se riuscivano, anche quelle
sui castagni; rota perché giravano intorno ai
castagneti per cogliere il momento in cui, non
viste, potevano entrare dentro, mosse dal detto che
“la castagna della strada e della proda è di chi se
la piglia”, trasformato facilmente nell’altro “la
castagna è di chi primo se la piglia”.
Forse in questa zona,
chiamata rotone (un accrescitivo) vi erano
castagneti che presero questo nome da questa antica
usanza.
|

Bettolle, "Mulino di Rotone" |
|
|
SALARCO
(torrente) Lungo 15 chilometri, 1 a Sinalunga, 12 a
Montepulciano e 2 a Torrita.
Ipotesi etimologica:
Salarco ha una base sal(a), voce
prelatina (è un tema idronimico) che sta per ‘corso
d’acqua, canale, acquitrino’404. Per l’altro
elemento, arco, sono possibili tre ipotesi:
1) Derivazione
dal nome personale latino Arcius.
2) Forse
potrebbe essere connesso al latino arcus,
‘arco’, con allusione ad es. alla curvatura del
corso d’acqua.
3) Possibile
anche una relazione col latino arx, arcis,
‘rocca’, nel senso di altura, parte elevata, ecc..
Salarco ha dei
paralleli, da un punto di vista toponomastico, in
Salandra (MT) e, secondo alcune interpretazioni,
anche con i celebri toponimi Salerno e
Salento.
Riguardo alla diversa
composizione del nome Salarco (una base
prelatina e un suffisso latino), in toponomastica
non è raro che ad una voce preindoeuropea venga poi
accostato formalmente un suffisso latino.
|

Ponte sul Salarco -
allacciate di sinistra |
SALCIAIA -
Torrita di Siena - Primo e secondo podere della
Salciaia - Lo stato attuale dei due poderi
differisce molto dal progetto originario.
Nella ristrutturazione sono stati mantenuti i muri
portanti ortogonali alla facciata, con i loro
interassi. E' facile notare come gli interassi più
ampi siano interni, mentre i due più piccoli esterni
fungono da contrafforte agli archi molto ribassati
degli interassi interni.
Gli interassi più piccoli esterni sono intervallati
da archi e da muri pieni traversi, così da reggere
meglio la spinta che proviene dal centro.
La Salciaia è un esempio tipico della risposta
costruttiva alle necessità del momento.
La pianta del 1779, pur presentando gli stessi
quattro interassi, ha un avancorpo del tutto diverso
e abbastanza insolito: non vi sono i due grandi
portici ad arco, poiché l'ingresso alle scale e alle
stalle era laterale e non sulla facciata.
Il toponimo richiama
un podere caratterizzato da terreni piantati a
salice.
|

Torrita di Siena
- casa Leopoldina dei Poderi I e II
della Salciaia |
SAGGINALI -
Abbadia di Montepulciano - Podere Sagginali I e II -
Caso unico nel senese. Il Sagginale è anche
il fusto secco della saggina.
Più in generale il
nome del podere richiama la saggina, pianta
erbacea coltivata come foraggio fresco e per le
cariossidi utili come concime.
|

Abbadia di
Montepulciano - casa Leopoldina dei
Poderi I e II Sagginali |
SCIARTI - (I,
II, Sciarti Nuovi, Sciarti Bassi) Toponimo unico. È
anche il nome di una frazione del comune di
Montepulciano. C'è anche Via degli Sciarti.
Un articolo di
Alessandro Angiolini, Sciarti e la sua antica
storia dimenticata. Eccone il brano iniziale:
«Durante la stesura della terza edizione del suo
fortunato libro "Prime comunità cristiane e strade
romane nel territorio di Siena - Arezzo - Chiusi",
feci notare a don Alfredo Maroni, l'esistenza di un
podere chiamato Strada sulla direttrice della Cassia
Adrianea in località Sciarti, nei pressi di Abbadia
di Montepulciano e facilmente riscontrabile in tutte
le carte topografiche.
Il
podere aveva lo stesso nome di quello situato nella
vicina Gracciano, nei pressi del torrente Salarco,
un toponimo descritto dal Maroni nelle sue due prime
edizioni ed identificato su una diramazione della
strada romana.
Alla Parcese (Stazione di Montepulciano), la Cassia
Adrianea attraversava il torrente Salarco (il
percorso naturale del più importante corso d'acqua
polizianò fu modificato e deviato verso nord a
partire dal 1849 dall'ingegnere idraulico granducale
Alessandro Manetti) procedendo in rettilineo per
Caselle fino alla "villa della Strada" a Sciarti.
Mi è stato raccontato da alcuni abitanti del posto,
che in passato, durante gli scassi profondi degli
aratri dei trattori nei terreni agricoli intorno al
podere Strada, sono emersi a volte dei grossi pezzi
di pietra liscia che potrebbero testimoniare la
presenza dell'antico selciato.
A
chi può obbiettare tale ipotesi affermando che è
impossibile con un mezzo agricolo arrivare alla
profondità dove si trova il selciato della Cassia
Adrianea dato che le campagne della Valdichiana
bonificate con la tecnica delle colmate sono state
rialzate da spessi sedimenti lasciati dalle piene
dei torrenti, rispondo che non è il caso di Sciarti,
dato che in questo luogo la palude non arrivò mai.
La linea d'acqua
del lago stagnante iniziava all'incirca un
chilometro più a est, in direzione del Canale
Maestro, nei pressi dell'odierna chiesa di Sciarti
(quella antica, forse di origine medievale, si
trovava proprio davanti al podere Strada) costruita
nel 1833 per volere del granduca di Toscana Leopoldo
II nei terreni bonificati della fattoria granducale
di Abbadia».
L'autore cita antichi documenti poliziani con
l'elenco di villaggi del distretto di Montepulciano.
E aggiunge: «Da questi elenchi così precisi, non
risulta mai il nome della località Sciarti, ma si
trova invece quello di Villa della Strada. Viene
menzionata una contrada denominata "Stradelle" che
può essere probabilmente riconosciuta nella "Villa
della Strada" poi diventata Sciarti».
In conclusione, Strada, Villa della Strada e
Stradelli potrebbero essere i progenitori di
Sciarti.
Come si è passati da
strada a sciarti? Nel corso dei secoli molti
toponimi originali sono stati "corrotti" (come si
dice in linguistica) per una serie di ragioni legate
alla percezione popolare, alla parlata dialettale, a
errori di scrittura, ecc.
Si parte da strada,
dal latino strata(m), a sua volta sostantivo
femminile di stratus, participio passato di
sternere, "stendere, lastricare"; con innesto
di strato/strati (già presente
nell'etimologia di strada, ma forse con allusione a
strati/livelli/ terrazze del
territorio?).
Forse con un po' di
fantasia si potrebbe immaginare la seguente "catena
etimologica" strada/strata > strati > sctrati
(cioè una pronuncia con la "s" di scia,
"strati") > shrati > sciarti (quest'ultimo
per metatesi, cioè inversione di una sillaba).
È solo una prima
congettura per spiegare questo toponimo più unico
che raro. Una seconda ipotesi potrebbe essere quella
ottenuta procedendo da strada/stradelle:
immaginando l'espressione completa "le stradelle" o
"alle stradelle", per indicare il luogo, si avrebbe
alle stradelle/stratelle > le
stratelle > lestratelle (agglutinazione
dell'articolo) > lecstratelle (dove il nesso
"cs" percepito come "x" porta a "sc",
come Axiano > Asciano) > shtratelle
> shtrate > shtrati > shrati > sciarti.
|

Comune di
Montepulciano - zona Sciarti |
|
|
VIGNACCE
(Bettolle) Il
riferimento è abbastanza evidente, dal latino
vineam, alla vigna, ai vigneti, aspetti
caratteristici di determinate contrade o zone. Il
toponimo è formato anche con il suffisso -accio,
spregiativo, peggiorativo, spesso usato in toscano;
incontriamo anche, al singolare, Vignaccio a
Grosseto.
VIGNACCE
(podere)
|

Bettolle - zona
Vignacce |
|
|
 |
